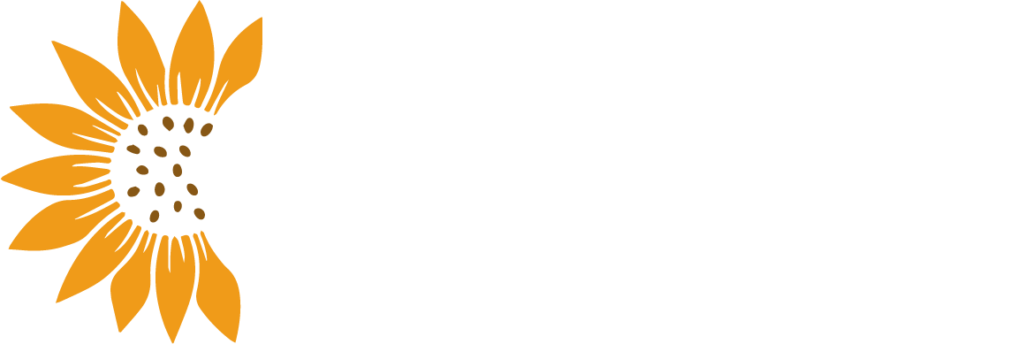Negli ultimi decenni la scienza ha rivoluzionato il nostro modo di comprendere l’impatto del trauma psicologico, svelando qualcosa che i terapeuti sospettavano da tempo: le esperienze traumatiche non si fermano con chi le vive, ma possono lasciare tracce profonde anche nella generazione successiva. E non solo attraverso i comportamenti o l’ambiente familiare, ma a livello biologico, molecolare, epigenetico.
Cosa significa “epigenetica”?
L’epigenetica è la disciplina che studia i meccanismi attraverso cui l’ambiente e le esperienze modificano l’espressione dei nostri geni senza alterare la sequenza del DNA. In altre parole: il nostro codice genetico resta lo stesso, ma interruttori molecolari — come i gruppi metilici o le modificazioni istoniche — possono accendere o spegnere l’attività di specifici geni, influenzando la produzione di proteine e, di conseguenza, il funzionamento del nostro organismo.
Queste modifiche epigenetiche possono essere indotte da fattori ambientali, come:
- stress cronico,
- malnutrizione,
- esposizione a sostanze tossiche,
- e — soprattutto — traumi psichici intensi.
Ma la scoperta davvero rivoluzionaria è che queste modifiche possono essere trasmesse alla generazione successiva.
Il trauma che attraversa le generazioni
Una delle ricerche più celebri in questo campo è quella condotta da Rachel Yehuda, psichiatra e ricercatrice americana, sul trauma dei sopravvissuti all’Olocausto. Yehuda ha osservato che i figli di genitori sopravvissuti ai campi di concentramento presentavano livelli alterati di cortisolo, un ormone fondamentale nella regolazione dello stress. Il loro profilo endocrino risultava diverso rispetto a quello di coetanei non esposti a traumi transgenerazionali, suggerendo una trasmissione biologica del trauma.
Un’altra ricerca significativa riguarda le madri incinte durante l’assedio di Sarajevo. Gli studi hanno evidenziato che i bambini nati da donne esposte al terrore della guerra presentavano a distanza di anni alterazioni nei geni legati alla risposta allo stress, in particolare nei recettori dei glucocorticoidi. Anche in questo caso, si tratta di modificazioni epigenetiche, non di mutazioni genetiche vere e proprie.
Come si trasmette il trauma?
Il meccanismo più studiato riguarda il cosiddetto asse HPA (ipotalamo-ipofisi-surrene), ovvero il sistema che regola la risposta allo stress. Le esperienze traumatiche infantili, come l’abuso, la trascuratezza o il vivere in ambienti instabili, possono portare a una sovraregolazione o sottoregolazione di questo asse, con effetti duraturi sulla salute mentale e fisica.
Quando questi cambiamenti avvengono in età fertile, possono influenzare le cellule germinali (ovuli o spermatozoi) e quindi essere trasmessi biologicamente alla prole.
La buona notizia: si può cambiare
Forse il dato più importante — e incoraggiante — che emerge dalle ricerche epigenetiche è questo: le modificazioni epigenetiche non sono scolpite nella pietra. Sono reversibili.
Numerosi studi hanno dimostrato che interventi psicoterapeutici efficaci, ma anche esperienze riparative come:
- relazioni affettive sicure,
- ambienti stabili e accoglienti,
- tecniche di mindfulness,
- attività fisica regolare,
- alimentazione sana,
- e pratiche terapeutiche come l’EMDR,
possono modulare l’espressione genica e riprogrammare in senso più equilibrato l’asse dello stress.
Ad esempio, alcuni studi hanno mostrato che la psicoterapia può normalizzare i livelli di cortisolo e modificare i pattern epigenetici in soggetti con disturbo post-traumatico. La mente che guarisce, quindi, dialoga con il corpo e ripristina armonia anche nel codice biologico.
Perché è importante curare anche i genitori
Quando un genitore ha vissuto traumi non elaborati — magari ereditati dai propri genitori — può, senza volerlo, trasmettere un ambiente affettivo disorganizzato, iperprotettivo o caoticamente ansiogeno. Non solo: le sue tracce biologiche di stress possono essere passate direttamente ai figli.
Ecco perché intervenire con la psicoterapia su adulti che hanno vissuto infanzie difficili non è solo un atto di cura personale, ma un gesto di prevenzione intergenerazionale. Curare un genitore oggi significa proteggere la salute mentale di un figlio domani.
Conclusione
Il trauma può lasciare cicatrici profonde, anche nel corpo. Ma la nostra biologia è molto più flessibile e aperta al cambiamento di quanto si pensasse. Le neuroscienze e l’epigenetica ci stanno dicendo che non siamo prigionieri del nostro passato, e che ogni percorso di consapevolezza e guarigione può innescare un cambiamento anche molecolare.
Ricordiamoci: la psicoterapia non solo libera la mente, ma aiuta il corpo a respirare un’aria nuova. E quell’aria può diventare un’eredità diversa, più leggera, per chi verrà dopo di noi.