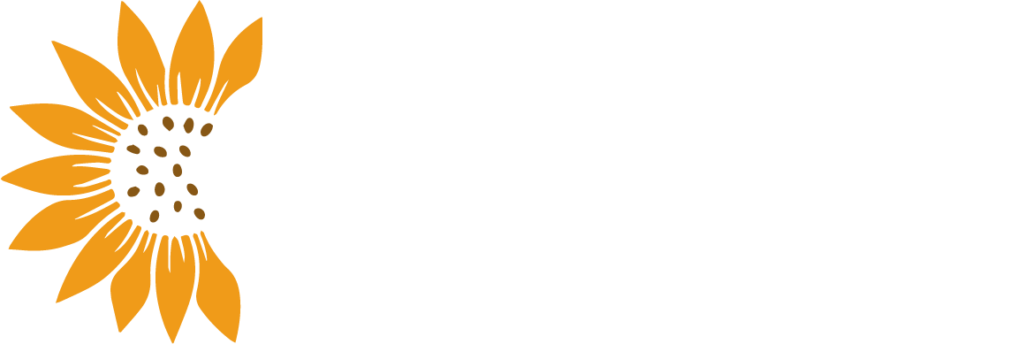“Mi manca il mio calcio, comportamenti meno esasperati. Mi piacerebbero meno creste sui capelli e più lanci di quaranta metri o dribbling riusciti.”
Dino Zoff
Ci sono frasi che andrebbero lette e rilette, lentamente. L’intervista a Dino Zoff – uno dei più grandi portieri italiani – prosegue e le sue parole non parlano solo di sport, ma di uno stile, di un’epoca e di un modo di crescere.
Quando dice che “manca l’oratorio” e che “i campetti sono tutti chiusi a chiave”, non sta manifestando solo nostalgia di un tempo passato che ora non c’è più. Sta mettendo in luce una verità che chi lavora con i bambini oggi vede ogni giorno.
Fino a pochi decenni fa, per giocare a calcio bastava un pallone (vero o di fortuna), qualche sasso per fare le porte e uno spiazzo qualunque. Bastava la strada. Bastava il campetto dell’oratorio, magari con un parroco che ti levava il pallone se non andavi a messa. Non che oggi ogni spiazzo non sia buono per giocare a palla, ma l’oratorio, il luogo dove trovarsi con continuità ed usufruire di uno spazio protetto, quello manca.
Una volta c’era libertà, movimento, confronto. E anche gerarchie spontanee: il più bravo veniva scelto per primo, ma tutti giocavano. Tutti avevano diritto di provarci. Tutti miglioravano.
Oggi, per giocare a calcio, bisogna entrare in una società sportiva. Pagare una quota. Avere divise, scarpe giuste, zaini personalizzati. E, a volte, non basta nemmeno questo.
Molti bambini che incontro nel mio lavoro, pur iscrivendosi con entusiasmo a una squadra, finiscono per sentirsi esclusi. Perché non giocano mai. Perché magari non hanno “gli agganci giusti”. Perché – pur avendo voglia e talento – non fanno parte della cerchia di quelli con un genitore influente nella società sportiva. O, diciamolo con le parole che usano spesso loro: “perché io non sono della casta”.
È un’espressione che colpisce. Perché rivela quanto i bambini percepiscano dinamiche che nulla hanno a che fare con il gioco. E che invece somigliano troppo al mondo adulto, competitivo, selettivo e spesso poco equo.
Abbiamo perso una bellissima abitudine: quella di ritrovarsi spontaneamente per il piacere di giocare. Di imparare dall’errore. Di misurarsi con l’altro senza troppe regole scritte, ma con un codice non verbale che teneva insieme spirito di gruppo, fatica, gioia, libertà.
Lo sport dovrebbe essere tutto questo.
Un linguaggio universale, che educa al rispetto, all’impegno e all’espressione di sé.
Un diritto, non un privilegio.
E forse bisognerebbe cominciare a chiederci: quante storie stiamo perdendo dietro le panchine troppo lunghe, gli allenatori urlanti e le classifiche prematuramente interiorizzate? Quanti bambini stanno smettendo di credere nel gioco perché si sentono già fuori dai giochi?
Tornare a parlare di sport di strada, di oratori aperti, di campetti senza chiavi, non è un vezzo romantico. È un’urgenza educativa.
Perché – come dice Zoff – dai campetti uscivano i campioni. E non solo quelli del calcio.
Anche quelli della vita.