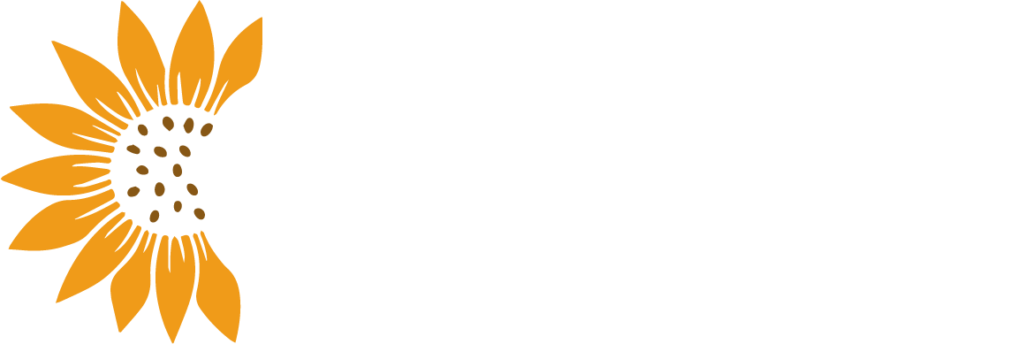Uno sguardo psicologico ad uno dei dipinti più inquieti della storia dell’arte
Chi era Edvard Munch?
Edvard Munch (1863–1944) fu un pittore norvegese dalla sensibilità intensa, segnato fin dall’infanzia da lutti e malattia. Perse la madre a soli 5 anni e poco dopo anche la sorella, eventi che lo spinsero a riflettere fin da giovanissimo sul dolore, l’angoscia, la solitudine e la morte. Cresciuto in un ambiente rigido e religioso, sviluppò un’immaginazione fervida, a tratti ossessiva, che riversò nella sua arte. Munch non dipingeva per decorare le pareti, ma per esprimere le crepe della psiche umana. Nei suoi quadri, i sentimenti non vengono rappresentati: vengono vissuti, come esperienze viscerali, intime, universali.
L’Urlo: molto più di un grido
Realizzato nel 1893, L’urlo non è solo un’icona culturale: è la rappresentazione tangibile di un momento di collasso interiore. Munch stesso descrisse l’episodio che ispirò l’opera in questi termini:
“Camminavo lungo la strada con due amici – il sole stava tramontando – sentii un soffio di malinconia – il cielo divenne rosso sangue – mi fermai, mi appoggiai al recinto, esausto – lingua di fuoco e sangue sopra il fiordo blu-nero e la città – i miei amici continuarono a camminare – io tremavo ancora di paura – e sentii che un urlo infinito attraversava la natura.”
Questo “urlo infinito” non esce dalla bocca del personaggio al centro del quadro. Al contrario, sembra che il grido venga dal paesaggio stesso, dal cielo contorto, dai colori saturi, dalla vibrazione della realtà. L’umano, al centro, si chiude le orecchie: non urla, ma sente l’urlo del mondo e della sua psiche fondersi.
L’angoscia esistenziale in forma pittorica
Da un punto di vista psicologico, L’urlo è una rappresentazione dell’angoscia – non l’ansia momentanea, ma l’angoscia più profonda e paralizzante, quella che nasce quando il senso dell’Io si frammenta. Questo “collasso dell’Io” descrive quel momento in cui la mente non riesce più a contenere l’emozione e il soggetto si sente disgregare. Ecco, Munch dipinge proprio quel momento: il perdersi nella paura, il senso di alienazione dalla realtà, la perdita di contorni.
Il volto della figura è androgino, quasi infantile, ma soprattutto privo di identità. Non ha genere, non ha età, non ha storia. È un simbolo, un contenitore vuoto invaso da un’onda emotiva troppo grande per essere gestita. Anche il paesaggio contribuisce a questo senso di smarrimento: la passerella su cui si trova il personaggio dà l’illusione di un appoggio, ma è sottile, sospesa, instabile. I due personaggi sullo sfondo, indifferenti, rappresentano forse la normalità da cui il protagonista si sente escluso.
Una dissociazione emozionale?
In chiave psicodinamica, si potrebbe leggere l’opera come una dissociazione: il Sé osserva da fuori un’emozione troppo intensa per essere integrata. L’urlo non è un’espressione, è una percezione. Come capita a volte nei disturbi dissociativi o nelle crisi di panico, ciò che si sperimenta è un cortocircuito tra dentro e fuori, tra ciò che si sente e ciò che si vede.
Lo sfondo si muove, il cielo si deforma, la realtà diventa soggettiva, vischiosa, travolgente. Ed è proprio in questa deformazione che Munch riesce a comunicare un’esperienza emotiva difficile da spiegare a parole.
Il lascito di Munch alla psicologia dell’arte
L’urlo non è solo un capolavoro dell’Espressionismo: è una finestra su quella zona dell’umano in cui la vulnerabilità non ha più difese. Per chi si occupa di psicologia, questo dipinto è uno strumento potente per parlare di ciò che non si vede: dell’angoscia silenziosa, della paura del vuoto, del bisogno di essere compresi anche quando le parole mancano.
In fondo, Munch non ci mostra qualcuno che urla. Ci mostra ciò che si sente quando si vorrebbe farlo ma non si riesce più nemmeno a trovare la voce per parlare.