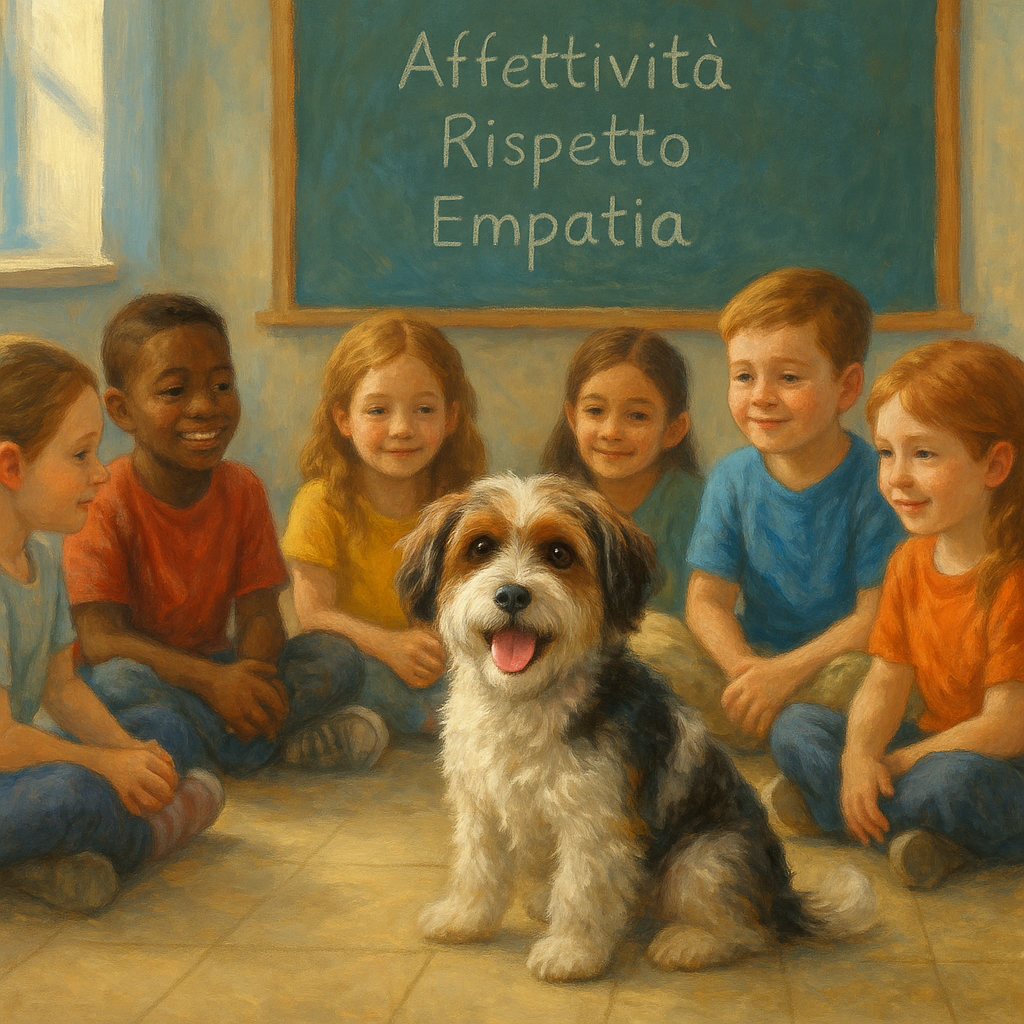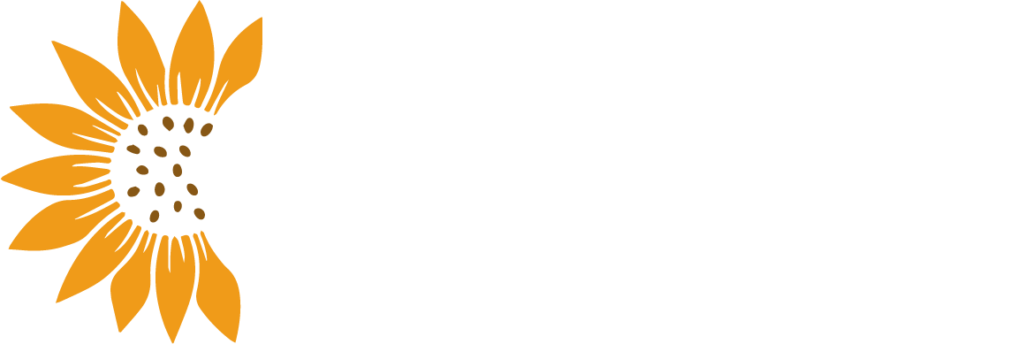Nel mese scorso l’Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha inviato al Governo e al Parlamento italiano una lettera in merito agli emendamenti che tendono a escludere l’inserimento dell’educazione affettiva e sessuale nei percorsi scolastici (Disegni di legge C. 2423, C. 2271 e C. 2278).
In essa si sostiene che l’esclusione di questi percorsi costituisce «un passo indietro su un tema fondamentale per la crescita sana e consapevole delle nuove generazioni».
Vive-oggi una realtà in cui i femminicidi, la violenza di genere, gli abusi tra fratelli e sorelle, le dinamiche di dominio nei rapporti sessuali, la superficialità dell’atto corporeo senza integrazione affettiva: tutti questi fenomeni richiedono, più che mai, che la scuola, la cultura, l’educazione all’affettività e al rispetto siano parte integrante di un percorso formativo.
Ma cosa significa “educazione affettiva” nel contesto attuale? E quali modelli esistono all’estero che possono aiutare a comprendere la direzione da prendere — ad esempio in Asia, in particolare in Corea del Sud?
Infine, come psicoterapeuta che opera nel reale, voglio condividere la mia esperienza concreta con ragazz* che hanno partecipato a un corso di educazione affettiva, per riflettere insieme su ciò che è possibile — e su ciò che rischiamo di perdere.
Il contesto italiano: segnali di allarme e silenzi educativi
Nella quotidianità del mio studio arrivano sempre più ragazze e ragazzi che hanno subito abusi — in famiglia, fuori famiglia — spesso da fratelli o da coetanei. Dinamiche in cui la sessualità è vissuta come atto di dominio, di sfogo, senza componente affettiva, senza riconoscimento dell’altro come soggetto, e nella quale l’idea del “sentire” e del “prendersi cura” appare estranea.
Allo stesso tempo, assistiamo a episodi di violenza giovanile che colpiscono tutti: dodicenne accoltella un compagno nel cortile della scuola (Marino- Roma 2024), 15enne uccide un’amica di famiglia a Milano (maggio 2025)… Due episodi su tanti che evidenziano come tra i giovani ( e non solo) ci sono atti di violenza grave, aggressività, impulsività che lasciano poco spazio al pensiero affettivo e relazionale.
La mancanza di modelli, l’assenza di spazi in cui parlare di sviluppo affettivo e sessuale con linguaggio adeguato, la reticenza dei genitori o della scuola nel toccare questi temi: tutto questo contribuisce a un terreno fertile per disinformazione, stereotipi, violenza, bullismo, cyberbullismo, revenge-porn.
L’atto di vietare, o di sottrarre dalle scuole un percorso di educazione affettiva, rischia dunque di essere un ostacolo — come l’Ordine scrive — allo sviluppo sessuale, affettivo e relazionale di bambini e adolescenti.
È importante sottolineare che “educazione affettiva” non significa solo “come si fanno i bambini” né solo “educazione sessuale tecnica”, ma soprattutto: competenze emotive, relazionali, di empatia, rispetto reciproco, capacità di riconoscere e gestire le emozioni e comprendere le differenze di genere, di ruolo, di potere.
Quando queste competenze mancano, la sessualità rischia di diventare atto strumentale, la relazione un dominio, l’altro oggetto, anziché soggetto.
In questo senso, ritenere che la scuola possa restare “neutrale” su tali temi è un’illusione: la neutralità è essa stessa una scelta educativa che ha conseguenze.
Uno sguardo altrove: la Corea e l’arte del NUNCHI
Mentre in Italia discutiamo se sia opportuno o meno parlare di affettività e sessualità a scuola, in altri Paesi si investe da anni sull’educazione emotiva come base della convivenza civile.
In Corea del Sud, ad esempio, esiste un concetto profondamente radicato nella cultura: il NUNCHI (눈치).
Letteralmente significa “misurare con gli occhi”, ma nella sua essenza indica la capacità di percepire intuitivamente lo stato emotivo dell’altro, di leggere l’atmosfera relazionale e di comportarsi con sensibilità e rispetto.
Il NUNCHI non è una materia scolastica in senso stretto, ma un vero e proprio allenamento alla consapevolezza sociale, un’educazione informale che accompagna bambini e adulti per tutta la vita.
Fin da piccoli, i bambini coreani imparano a cogliere i segnali sottili: il tono della voce, lo sguardo, la postura. Imparano a sintonizzarsi con l’altro, a capire quando è il momento di parlare e quando è meglio tacere, quando un compagno è a disagio o ha bisogno di essere coinvolto.
È una forma di empatia pratica, quotidiana, che non si insegna con le parole ma con l’esempio, la presenza, l’attenzione.
Potremmo dire che il NUNCHI è una disciplina dell’ascolto emotivo.
Richiede lentezza, osservazione, sospensione del giudizio.
Non si tratta di reprimere se stessi, ma di sviluppare un equilibrio tra il proprio mondo interno e quello dell’altro.
In una società come la nostra, in cui l’impulso spesso precede il pensiero e la parola sovrasta il silenzio, il NUNCHI rappresenta un modello prezioso: educa a fermarsi, a percepire, a comprendere.
Ecco perché guardare a esperienze come questa può aiutarci a comprendere quanto sia riduttivo pensare che l’educazione affettiva significhi solo “parlare di sesso”.
È invece un modo per allenare la sensibilità relazionale, la capacità di riconoscere le emozioni proprie e altrui, di costruire rispetto e fiducia.
Dove c’è NUNCHI, c’è empatia; e dove c’è empatia, la violenza trova meno spazio.
Perché l’educazione affettiva / sessuale è un investimento, non un optional
Ecco alcune ragioni — che possiamo esplicitare anche ad un pubblico di genitori e docenti — per cui reputo fondamentale inserire percorsi di educazione affettiva e sessuale nelle scuole:
- Fase adolescenziale cruciale: L’adolescenza è un momento di formazione dell’identità personale e relazionale. Non solo “cosa faccio” ma “chi sono”, “come mi rapporto all’altro”, “come vivo la sessualità”.
- Prevenzione della violenza: Le abilità affettive e relazionali — empatia, capacità di riconoscere l’altro, regolazione degli impulsi — sono fattori protettivi nei confronti della violenza di genere, del bullismo, del cyberbullismo.
- Riduzione della disinformazione: In assenza di spazi educativi qualificati, i ragazzi e le ragazze ricorrono a fonti non affidabili — internet, pornografia, modelli distorti — e interiorizzano stereotipi relazionali disfunzionali.
- Promozione dell’autonomia emotiva: Non si tratta solo di evitare rischi, ma di favorire che il giovane “sappia stare” con sé e con l’altro, capisca i propri desideri, i propri limiti, il consenso, il rispetto.
- Investimento sulla salute psicologica: Il ben-essere relazionale è una parte importante della salute mentale, che la scuola non può ignorare.
- Cooperazione scuola-famiglia-studente: L’educazione affettiva può inserirsi nel “Patto di Corresponsabilità” tra scuola, famiglia, studenti come base per un’alleanza formativa.
Quando tutto questo manca, il rischio è che la scuola non risponda al bisogno affettivo-relazionale dei giovani, lasciando un vuoto che viene riempito da modelli disfunzionali. E nel mio lavoro clinico questo vuoto lo vedo ogni giorno: ragazze che non sanno riconoscere l’affetto o il rispetto, ragazzi che vivono la sessualità come prestazione, come dominio, come strumento.
La mia esperienza in aula: un corso di educazione affettiva che ha funzionato
Qualche anno fa, alcuni genitori mi hanno proposto di tenere un corso di educazione affettiva (pagandolo autonomamente) per una scuola — una quinta elementare + primi anni di media. Purtroppo le scuole non hanno accettato — così i genitori hanno affittato una sala e ho tenuto io il corso.
Il percorso si è concentrato non (soltanto) sul “come si fanno i bambini”, ma sulla dimensione affettiva: empatia, visione dell’altro, ruoli, differenze e uguaglianze, sessualità come relazione e non solo atto fisico.
I risultati sono stati sorprendenti: i ragazzi hanno imparato a vedere gli altri in modo diverso, a mettersi nei panni di un compagno, a riflettere su cosa significhi rispetto, diversità, uguaglianza. Ho visto nei loro occhi un cambiamento: la curiosità, la partecipazione, la domanda. Abbiamo superato imbarazzi e tabù con una risata.
Personalmente non capisco la paura che si possa fare un argomento del genere: parlare di affettività, amore, rispetto dell’altro — non è un rischio, è un’opportunità. In un mondo in cui siamo sempre più esposti a violenza, sopraffazione, depressione, odio sparso come se fosse sale su un piatto, la scuola può (e deve) essere uno spazio di luce relazionale.
Quali implicazioni per la professione e per la scuola
Come psicoterapeuta lavoro spesso al confine tra scuola, famiglia, individuo. E posso dire che:
- Il professionista che entra nelle scuole con competenza etica e deontologica può offrire un valore aggiunto significativo: non solo “informazione”, ma lavoro su relazioni, emozioni, prevenzione.
- I docenti e i genitori devono sentirsi parte attiva del percorso affettivo-relazionale dei giovani, non solo spettatori.
- Le istituzioni scolastiche devono aprire spazi — non episodici, ma strutturati — in cui l’affettività, la sessualità, la relazione sono trattate come dimensioni umane profonde, non emergenze o optional.
- Le politiche scolastiche che escludono questi percorsi rischiano di ignorare la complessità della formazione dei giovani, e potenzialmente aumentare il rischio di disagio, violenza, isolamento.
Quali proposte operative – e qualche suggerimento per chi lavora con i giovani
- Introdurre moduli di educazione affettiva e sessuale nei piani formativi, differenziati per età, condotti da professionisti competenti.
- Favorire nei percorsi scolastici esperienze di Empatia: role-play, laboratorio di emozioni, riflessione su relazioni e differenze, interventi su bullismo e violenza. (In Corea, ad esempio, i programmi di apprendimento socio-emotivo mostrano efficacia nella regolazione emotiva e nell’empatia)
- Creare alleanze scuola-famiglia-professionista: i genitori devono essere coinvolti, informati, preparati a dialogare con i ragazzi su affettività e sessualità.
- Monitorare e valutare: non basta fare un incontro una tantum. Occorrono percorsi strutturati, con monitoraggio dei risultati, feedback, adeguamento.
- Promuovere una cultura del “rispetto dell’altro” come valore educativo centrale: ugualmente rilevante dell’apprendimento tecnico o disciplinare.
Conclusione: un invito alla responsabilità educativa
In conclusione, ritengo che la scelta politica ed educativa di escludere l’educazione affettiva e sessuale dalla scuola non sia un semplice “risparmio” o “riduzione di materia”, ma una decisione che riguarda la qualità delle relazioni, della crescita emotiva e affettiva dei giovani, e in definitiva della nostra società.
Guardando a esperienze internazionali — come la Corea del Sud — vediamo che inserire competenze socio-emotive, empatia, regolazione delle emozioni, è considerato un investimento.
Nel mio lavoro ho visto che è possibile: con genitori motivati, con spazi, con parola. E allora mi chiedo: perché avere paura di parlare di affettività? Perché temere di impegnarsi su amore, rispetto, emozioni?
Le nuove generazioni non meritano di essere lasciate senza strumenti. La scuola non può restare neutra: quando tace su affettività e sessualità, parla — ma parla di silenzio, di vuoto, di mancanza.
E come professionista della psicoterapia voglio invitare al coraggio: al coraggio di fare scuola che abbracci il cuore e la mente, che non lasci indietro il desiderio umano di relazioni autentiche, che riconosca che la sessualità e l’affettività non sono separabili dalla persona, ma ne costituiscono un nucleo centrale.
E quindi: facciamo in modo che la scuola sia davvero luogo di conoscenza, dialogo e crescita emotiva, nel rispetto della dignità di ogni persona.
Il tempo è adesso.
“fonti: CNOP, RaiNews, SkyTG24”